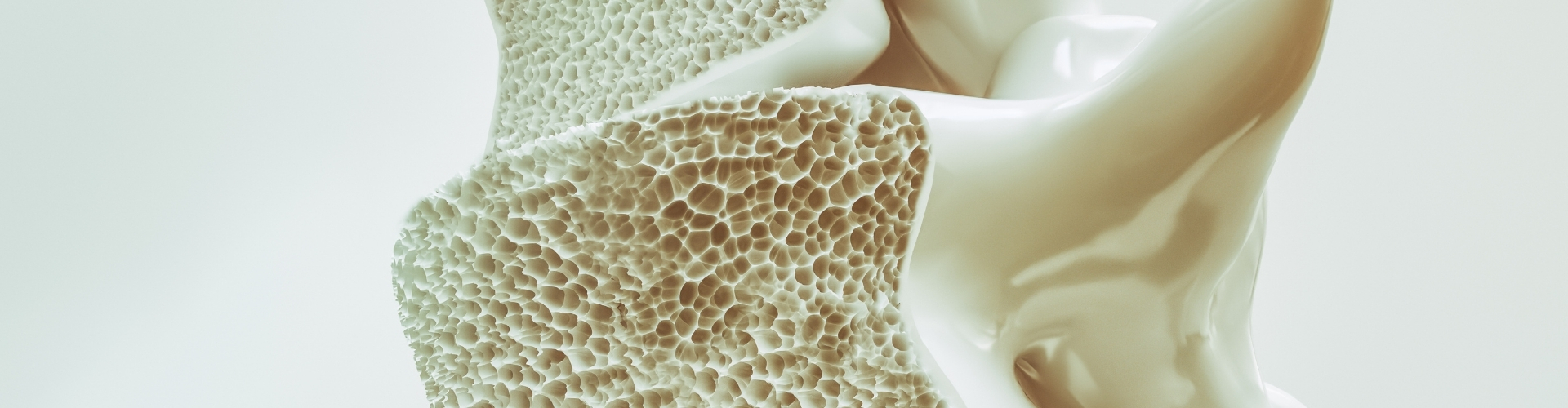Le malattie cardiache rappresentano una delle principali cause di morte nel mondo e in Italia, ma sono al contempo anche quelle per le quali è possibile fare maggiore prevenzione, come affermato da una recente statistica dell’Eurostat. La chiave per un cuore sano è adottare uno stile di vita salutare e sottoporsi a visite preventive regolari.
Di seguito vediamo quali sono le più comuni malattie cardiache, come prevenirle e quali visite di controllo è importante effettuare per mantenere il cuore in buona salute.
Malattie cardiache comuni
Le malattie cardiache possono assumere diverse forme e manifestarsi in modi diversi. Queste le più frequenti:
Malattia coronarica: è caratterizzata dalla formazione di placche nelle arterie coronarie, che forniscono sangue e ossigeno al cuore. Queste placche possono restringere le arterie e limitare il flusso sanguigno al cuore, causando dolore al petto (angina) e, in alcuni casi, un blocco completo delle arterie (infarto del miocardio).
Infarto del miocardio: comunemente noto come attacco di cuore, l’infarto del miocardio si verifica quando il flusso sanguigno verso una parte del muscolo cardiaco viene interrotto. Questo può causare danni permanenti al tessuto cardiaco e può essere fatale.
Insufficienza cardiaca: si verifica quando il cuore non pompa efficacemente il sangue in tutto il corpo. Può essere causata da diverse condizioni, come la malattia coronarica, l’ipertensione arteriosa o le malattie delle valvole cardiache. I sintomi includono affaticamento, gonfiore delle gambe e mancanza di respiro.
Aritmie: le aritmie sono disturbi del ritmo cardiaco. Possono manifestarsi come battiti cardiaci irregolari, accelerati o rallentati. Alcune aritmie possono essere innocue, mentre altre possono essere gravi e richiedere trattamento medico.
Malattie delle valvole cardiache: le valvole cardiache regolano il flusso di sangue attraverso il cuore. Le malattie delle valvole cardiache possono riguardare il restringimento delle valvole (stenosi) o la loro perdita di funzionalità (insufficienza). Ciò può causare un’alterazione del flusso sanguigno e sintomi come affaticamento, mancanza di respiro e gonfiore delle gambe.
Cardiomiopatia: è una condizione in cui il muscolo cardiaco diventa rigido, ispessito o debilitato. Ciò può influire sulla capacità del cuore di pompare sangue in modo efficiente e può portare a sintomi come affaticamento, palpitazioni e mancanza di respiro.
Prevenzione
La prevenzione delle malattie cardiache inizia con uno stile di vita sano. Il primo accorgimento è senza dubbio un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, evitando invece cibi ad alto contenuto di grassi saturi e transgenici, zuccheri aggiunti e sale in eccesso. Al contempo, è molto utile impegnarsi a fare esercizio fisico regolarmente; si consigliano almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata, come una camminata veloce, jogging e nuoto. Ciò contribuirà al controllo del peso, uno dei fattori chiave nel campo delle malattie cardiache.
Altri comportamenti correttivi essenziali sono lo smettere di fumare, pratica che aumenta notevolmente il rischio di malattie cardiache, e una migliore gestione dello stress, che quando è cronico può influire negativamente sulla salute del cuore; alcuni modi sani per gestirlo possono essere la mindfulness, lo yoga o l’attività fisica in generale.
Visite preventive
Oltre ad adottare uno stile di vita salutare, è essenziale sottoporsi a visite preventive regolari per monitorare la salute del cuore. Ecco alcune visite che bisogna considerare:
Visita dal medico di base: programma una visita regolare con il tuo medico di base. Durante questa visita, verranno valutati i fattori di rischio per le malattie cardiache, come la pressione sanguigna, il colesterolo e il diabete. Il medico potrebbe anche consigliare esami di laboratorio specifici per valutare la tua salute cardiovascolare.
Controllo della pressione sanguigna: la pressione sanguigna elevata è un fattore di rischio significativo per le malattie cardiache. Assicurati di controllare regolarmente la tua pressione sanguigna e di lavorare con il tuo medico per mantenerla sotto controllo.
Esami del sangue: alcuni esami del sangue possono aiutare a valutare il rischio di malattie cardiache. Misurare i livelli di colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL e trigliceridi può fornire indicazioni sullo stato di salute del cuore.
Elettrocardiogramma (ECG): un ECG registra l’attività elettrica del cuore. Può essere utilizzato per identificare anomalie nel ritmo cardiaco o segni di danni al cuore.
Ecocardiogramma: un ecocardiogramma utilizza ultrasuoni per creare un’immagine del cuore. Questa procedura può rilevare anomalie strutturali o funzionali del cuore.
Per appuntamenti: 0392103560, vai al nostro sito di prenotazione o scarica la nostra App Politerapico per Android o iOS.